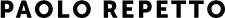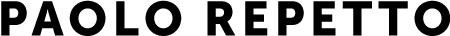La visione dei suoni
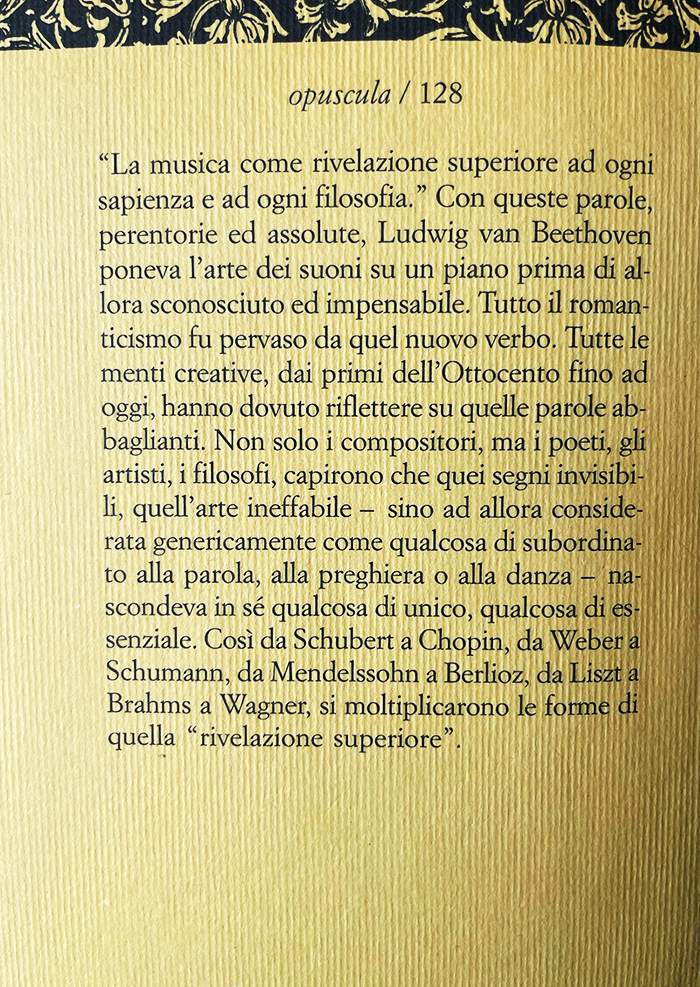
L’occhio dello spirito
La natura come luogo sacro. Il paesaggio come un’epifania.
Il cielo, la luna, gli alberi, l’orizzonte, le montagne, le rocce, il mare come segni di una divinità pervasiva e nascosta, presente e misteriosa. I geroglifici di una corteccia; le infinite lettere dell’universo in una simbologia senza tempo; l’immenso libro dell’aria dove le nuvole appaiono come una scrittura indecifrabile.
Nel cuore del Romanticismo tedesco, nessuno come Caspar David Friedrich e Carl Maria von Weber – ora con un disegno cristallino e ricchi colori ora con raffinati timbri e ampie melodie – ha rivelato il fascino della natura. Una rivelazione. Qualcosa che si ri-vela, che appare e subito scompare, che ci tocca, ci scuote, ci commuove con l’estrema bellezza delle sue forme; ma, appena dopo, ci ricorda la nostra limitatezza, il nostro essere mortale – noi uomini finiti che possiamo pensare l’infinito! – riportandoci dalla sacra intuizione di una gioia eterna ai nostri corpi imperfetti, al nostro ego meschino, alle nostre stanche coscienze, ai nostri dolori – noi angeli prigionieri del tempo.
Non ci sono documenti che testimoniano di un incontro personale tra Friedrich e Weber; tuttavia molti argomenti comprovano la loro profonda affinità. Entrambi vissero a Dresda nei primi decenni del 1800, dove ebbero riconoscimenti ed incarichi pubblici; entrambi amavano immensamente la natura; entrambi vedevano in essa il luogo della Divinità, lo spazio consacrato da Dio: “Lo splendore nascente del giorno si spiegava con una calma e una maestosa grandezza. Il crescendo sacro della natura si elevava nell’etere luminoso e trasformava il mio umore silenziosamente rassegnato in un presentimento sereno e raccolto. Con una fiducia gioiosa, il mio essere più intimo si volgeva verso Colui che, solo, dona e crea tutte le cose e che, come il miglior padre, aveva deposto nel fondo di me questo talento artistico che doveva ormai segnare la mia vita del suo sigillo e testimoniare altamente per Lui. Lui, che mi aveva confidato il pegno della sua benevolenza”. (Weber) “Il compito dell’artista non consiste nella fedele rappresentazione del cielo, dell’acqua, delle rocce e degli alberi; sono la sua anima e la sua sensibilità a doversi rispecchiare nella natura. Riconoscere, penetrare, accogliere e riprodurre lo spirito della natura con tutto il cuore e con tutta l’anima è dunque il compito di un’opera d’arte.” (Friedrich) Weber, tra il 1817 e il 1826, fu nominato prima direttore musicale, poi maestro di cappella dell’Opera di Dresda. Ispirato dai suoi ideali, maturati sin dall’infanzia in comunione con la grande passione teatrale dei suoi genitori, qui avrebbe vissuto l’ultima importante occasione per la costituzione di un’opera nazionale tedesca. Per contrastare il dominio in quel tempo indiscusso del melodramma italiano, per tutta la vita aveva lottato con impresari, registi, orchestrali, cantanti, affinché si realizzasse il suo sogno: l’invenzione di un’opera inconfondibilmente germanica, la progettazione di un nuovo rito nordico, con parole e musiche e scenografie tedesche: l’ideale che il suo genio concretizzò con tre capolavori: Der Freischütz (Il franco cacciatore, 1820), Euryanthe (1823) e Oberon (1826), dove l’idea wagneriana di Gesamtkunstwerk (l’opera d’arte totale) – in cui il suono, la parola, l’immagine e la coreografia si uniscono in un matrimonio felice – viene prefigurata.
La musica e la pittura, e qualsiasi altra forma d’arte, non potevano continuare a vivere di se stesse, senza prefiggersi una meta più grande, senza porsi un fine più alto. Friedrich, profondamente cristiano, amava ripetere le più belle parole di San Paolo: “Se parlo le lingue degli uomini e quelle degli angeli, ma non ho carità, sono un bronzo che risuona e un cembalo che tinnisce.” La pittura non poteva limitarsi ad una semplice riproduzione del mondo; la musica non poteva chiudersi nella semplice sfera dell’intrattenimento. Queste arti ancora giovani potevano continuare ad avere un senso soltanto testimoniando il mistero delle cose: l’effondersi di un’anima, l’elevazione spirituale, l’ansia della trascendenza – come devozione, come preghiera. Entrambi erano disgustati dalle persistenti influenze che provenivano dall’Italia: che senso aveva continuare a dipingere come Michelangelo e Raffaello, come facevano i Nazareni? che significato aveva persistere a scrivere melodie come Cimarosa e Paisiello? Così Friedrich e Weber, sganciandosi per primi dai modelli classici, dalle forme mediterranee, inventarono un’arte inconfondibilmente tedesca. “Chiudi il tuo occhio fisico così da vedere l’immagine principalmente con l’occhio dello spirito. Poi porta alla luce quanto hai visto nell’oscurità, affinché si rifletta sugli altri, dall’esterno verso l’interno.” (Friedrich) Anche per Weber, all’orecchio superficiale o esteriore andava sostituito l’orecchio interiore: uno strumento metafisico capace di cogliere nei segni della natura quei fremiti, quelle presenze, quei simboli che ci rivelano un mondo ulteriore; l’orecchio dello spirito, capace di scorgere anche in un suono apparentemente superficiale qualcosa di unico, come nel suo famoso Invito al valzer. Anticipando il teatro di Wagner, in questo modo Weber concepì una nuova forma di melodramma: un inedito universo sonoro non più fine a se stesso, ma indissolubilmente legato all’unità delle espressioni artistiche. Un evento musicale e scenico capace, come l’ideale greco, di congiungere più elementi disparati, più forze complementari, più dettagli apparentemente sparsi, per la rappresentazione della coscienza universale. L’infinito descritto in una forma, in un modo finito, come gli aveva insegnato Schelling. La Natura come Spirito visibile, e la Natura invisibile dello Spirito. Un suono come cosmo, una rappresentazione rituale, etica, che nella sua volontà di comprensione del mondo si trasforma magicamente diventando l’enigma del male, il volto dell’innocenza, la grazia del perdono: l’ombra della notte, l’argento della luna, gli spettri della nebbia: la vertigine del fuoco, il cinguettio degli uccelli, l’abbaiare dei cani: le ombre scricchiolanti del bosco, il viola remoto del vento, il muto brivido delle stelle. Friedrich visse tutta la sua vita terrena con la viva speranza che il tempo avrebbe presto annientato la propria nascita e i propri inganni. Aveva orrore dell’ego e del proprio io: per questo non volle mai firmare né datare i suoi quadri. Amava paragonarsi ad una crisalide: soltanto la storia avrebbe deciso se la sua umile opera si sarebbe trasformata in baco o, come avvenne, in farfalla variopinta. Era generosissimo. Pur guadagnando bene, morì povero per aver fatto molta carità. Conduceva un’esistenza solitaria, profondamente contemplativa. Faceva lunghe passeggiate, intridendo il proprio spirito nello spirito del mondo. Poi, rientrato a casa, abbandonava ogni immagine concreta. Allora il suo piccolo studio si trasformava in uno spazio liturgico, dove anche la sua discretissima moglie e i loro bambini avevano timore di entrare; una cella metafisica: spoglia, austera, senza decorazioni, senza mobili, con un solo sgabello, un cavalletto, e una squadra a forma di croce – il simbolo che più amava. Tutto ciò che era esterno doveva maturare nell’interno; tutto quello visto come apparenza doveva trasfigurarsi in una forma intima e sacra. Così la natura, questa splendida scenografia realizzata da Dio stesso – dove noi, piccolissimi uomini, recitiamo una parte ambigua e brevissima – con il suo pennello si trasformava nel simbolo supremo della Divinità. Come un mistico, Friedrich era pervaso dalla luce della morte; da bambino aveva perso la madre, e appena ragazzino aveva visto suo fratello scomparire in un crepaccio dei ghiacci, restando travolto dallo sforzo per salvarlo. Perché, gli domandavano, amava tanto i paesaggi notturni, i luoghi misteriosamente desolati, le vertigini dell’inverno, le cristalline efflorescenze della nebbia? Perché, gli avevano chiesto più volte, come soggetto dei suoi quadri dipingeva tanto spesso “la morte, la caducità e il sepolcro?” Poiché, spirito profondamente religioso, egli sapeva che per vivere eternamente spesso ci si deve arrendere a questa dea ineluttabile. Ma quale dea, quale morte? Quella buona, necessaria, vitale: quella che la nostra civiltà ha bandito con la sua furia antropocentrica e materialista.
Per Friedrich, come per Weber, “l’arte è infinita”; limitati sono soltanto il sapere ed il potere di tutti gli artisti e di tutti gli uomini. Dio è ovunque, “anche in un granello di sabbia.” Così la loro opera, simbolo dell’unione di forze apparentemente inconciliabili, da una parte rappresenta la visione, il sogno, l’immensità, la magia di spazi sterminati che si prolungano virtualmente oltre le cornici, al di là delle battute; dall’altra, questa vastità, questo contemplare atmosfere infinite, con un felice paradosso, si realizza attraverso una tecnica, una pennellata, un suono, estremamente precisi e minuziosi. Da una parte il macrocosmo della visione, dall’altra il microcosmo dell’artigianato; da un lato la rappresentazione sconfinata dell’universo, dall’altro la descrizione estremamente precisa del più piccolo particolare; in una mano l’infinitamente grande, nell’altra l’infinitamente piccolo. Poiché, come diceva Füssli, “il sapere è la base reale della visione.”
Gli arabeschi dell’aria
Sappiamo con precisione quanto la musica – fra Otto e Novecento – abbia influito sulla poesia e sulla pittura; possiamo valutare con una certa sicurezza quanto l’universo dei suoni, le forme dell’invisibile, abbiano condizionato e favorito la crescita di quei fiori prodigiosi. Incerto rimane il confine verificabile delle influenze opposte: le relazioni della poesia e della pittura sulla musica: sui suoni di Debussy. Nella seconda metà dell’Ottocento, la pittura smise di essere epica, magniloquente, eroica, per diventare umile, solare, evocativa; abbandonando le rappresentazioni storiche, i gesti retorici, si trasformò lentamente in un’elegia soffusa di grazia e di mistero, di polvere e di luce, in quel delicato canto naturalistico che pervade tutta la scuola di Barbizon: da Corot a Daubigny, da Rousseau a Troyon. Certo, il pubblico e i Saloni ufficiali rimasero ancora per qualche decennio ancorati al quadro celebrativo, all’iconografia tradizionale; ma le autentiche opere di quei pittori sono da ricercare nei bozzetti, nei lavori intimi, nei quadri che non potevano essere esposti e che non vendevano. Il sigillo del nuovo nasce, come sempre, nell’anonimato dell’intimità. Come per i poeti, anche per i pittori il suggerire divenne molto più importante del dire, l’evocare sembrò molto più interessante dell’esporre, e le certezze di un mondo consolidato si sfaldarono nei dubbi eterni della coscienza.
Fin da bambino Debussy fu affascinato dal mondo delle forme e dei colori. Il suo amico della prima giovinezza, Pierné, ci ricorda che spesso lo conduceva a casa sua, dove, in assenza dei genitori, si intrattenevano a lungo sfogliando una collezione rilegata del “Monde illustré”, in quegli anni una delle riviste più ricche d’immagini. Quelle riproduzioni con ampi margini bianchi di stampe e di famosi dipinti incantavano il piccolo Debussy, che convinceva il suo amico a ritagliarle, nonostante il divieto dei genitori, per adornare le pareti della sua camera. Quando ripensava all’infanzia, ripercorrendo le regioni sfumate di quel paradiso, talvolta confidava agli amici il suo inesauribile amore per la pittura, per le libere forme dei colori, ricordando che nella sua musica cercava sempre la freschezza improvvisa dell’abbozzo. Fino alla fine del primo matrimonio conservò con cura la tavolozza che aveva usato da bambino, e l’immagine di quelle luci informali, come un famoso dipinto di Sérusier, si proiettava nella sua coscienza come un talismano prezioso. Se il mondo contemporaneo della musica era ancora antiquato, conservatore, e per la maggior parte refrattario ai grandi rinnovamenti, egli vedeva nella poesia e nella pittura un universo in continua espansione, il luogo privilegiato di inedite emozioni; così i più importanti insegnamenti non gli vennero certo dai musicisti, ma “dai poeti e dai pittori”.
Andava spesso a visitare mostre e musei e un amico, al Louvre, lo vide contemplare quella grande tela che è Giove ed Antiope del Tiziano: volto assorto, busto leggermente inclinato, occhi fissi, la grande fronte pendente in avanti “come se volesse cogliere sull’acqua e sul prato del paesaggio divino, le supreme cadenze della montagna blu all’orizzonte, e i suoni e gli echi del corno da caccia”. A casa dell’amico Chausson aveva potuto ammirare i dipinti di Degas, Denis, Puvis de Chavannes, Monet; frequentando la famiglia Stevens, conobbe direttamente l’arte figurativa dell’Estremo Oriente. Poi, insieme a Camille Claudel – l’allieva di Rodin – conobbe i rari ma splendidi paesaggi a pastello di Degas, si innamorò delle stampe giapponesi, e “la Manga di Hokusai fu per loro una piccola Bibbia d’Amiens”. Quelle piatte figure dove il colore si incenerisce, quei paesaggi schematici in cui la pioggia si semplifica in linee ritmate; quei volti, quei campi, quegli alberi di vetro; quelle forme trasparenti e sigillate, incantarono i loro occhi e gli sguardi dei pittori impressionisti. I paradossi della prospettiva, le semplificazioni delle immagini, i colori distesi in superfici uniformi senza lo sfumato delle ombre – che tanto colpirono Manet – unirono i loro entusiasmi, indirizzando i loro intenti nell’ordine della semplicità. Debussy non amava l’arte complicata, antiquata, né le forme pesanti, la scultura eroica e monumentale di Rodin; ma le piccole sculture di Camille Claudel, i suoi impasti morbidi di bronzo e luce, lo conquistarono. Così per tutta la vita, quel piccolo gioiello di intimo lirismo che è La Valse, rimase custodito tra le pareti delle sue case.
Quando Debussy, con la sua mente, accarezzava quelle forme, si sentiva al riparo dai solenni consigli dell’Accademia: dai precetti di un’ideologia conservatrice che non voleva abbandonare i suoi sordi privilegi. Egli intuì che il suo spirito – seppure con mezzi differenti – era molto più vicino ai pittori impressionisti che non ai musicisti contemporanei. Quei pittori avevano abbandonato i musei per dipingere all’aria aperta, avevano superato le leggi dei padri: lo studio del disegno, la composizione delle ombre, i moduli della prospettiva, le gradazioni a tutto tondo, per rimescolare quei valori in un intarsio soggettivo di impressioni, di sensazioni, di luce. Tutti i preconcetti teorici e formali erano banditi. Tutte le formule accademiche erano messe in discussione: ogni riferimento al passato era sorpassato o almeno eluso: il flusso della coscienza, il tremito dell’inconscio, ricostruivano una realtà personale ed improvvisa. Il diritto della forma aveva affermato la sua superiorità sui contenuti. L’intuito scavava le acque, il vento, il cielo. La linea della teoria e del sistema, che si compendiava nel disegno, si era moltiplicata in una costellazione di punti. Il centro definito delle cose si era mutato in una periferia invisibile. La geometria mediterranea fece spazio a qualche barbarie nordica. Forse il più grande di questi eretici, Claude Monet, nel settembre 1870 aveva lasciato la sua famiglia a Le Havre, e si era imbarcato per Londra, dove, grazie al gallerista Durand-Ruel, incontrò Daubigny e Pissarro. Insieme riscoprirono la grande lezione di Constable e di Turner: rimasero colpiti da quei colori esagitati che non formano la natura, ma formano sé stessi; si entusiasmarono per quelle acque, quei bagliori, quei tramonti, che sul riflesso dei fiumi si incendiano come carta. Videro le ali del vento, le crepe delle nuvole, lo specchio del mare: il velluto del cielo, il riverbero delle nebbie, intuendo l’importanza straordinaria della coscienza, del sogno, che come una mano magica può rimodellare ogni cosa. Ed equilibrarono la loro preziosa tradizione, da Poussin a Corot, sul filo sospeso di quello spazio vertiginoso.
Debussy amava Turner come nessun altro pittore. Nel 1894 nella galleria Sedelmeyer a Parigi ne vide un’importante mostra; e durante il suo primo soggiorno a Londra, nel luglio 1902, visitò a lungo la Tate Gallery. Il pianista Ricardo Viñes ci racconta che durante una sua visita, Debussy gli fece ascoltare la sua ultima novità per pianoforte: Les Estampes. Al giovane pianista “quelle composizioni facevano pensare ai quadri” di quel fantastico pittore, ed egli gli rispose “che precisamente, prima di comporle, aveva passato un lungo momento nella sala dei Turner, a Londra!” Debussy amava intensamente questo fine visionario, poiché scorgeva nella sua opera una conferma alla sua musica: vedeva il colore sopraffare il disegno, l’intensa luce che compone la struttura, i toni, i timbri, che dominano e sostituiscono ogni concetto di classica ossatura e di rigida guida. Vedeva la libertà stessa che indicava l’ordine, un ordine superiore e inconscio che si sviluppa naturalmente come una pianta rigogliosa e misteriosa. Apprezzava il suo estremo amore per la natura, conoscendo forse alcune delle avventure che avvolgono il suo mito. Come quando, viaggiando con amici “lungo la costa verso Bur Island nel golfo di Bibury”, sopra un mare opaco e mosso, stava seduto a poppa della barca, impassibile, godendosi lo spettacolo. Alcuni avevano il mal di mare, ma Turner respirava l’aria e assaporava le onde. Poi, navigando intorno all’isola, riuscirono ad approdare e, arrampicatosi su un promontorio in mezzo al temporale, lo videro annotare fedelmente, con una matita, quel turbine d’aria, d’acqua e di luce. O come quando, fattosi legare al palo maestro di una barca, a rischio della vita, volle navigare al centro di una tempesta. Così, se l’ideale del pittore cinese è quello di trasformarsi lui stesso in bambù, il sogno di Turner era impossessarsi totalmente del mistero della natura, dell’aria, del mare; era assimilare profondamente le sue forze, i suoi elementi, trasformando la sua coscienza nella coscienza stessa del cosmo.
Come Turner, Debussy credeva nella magia dell’indeterminato, nell’incanto sconfinato dell’atmosfera che dialoga con le luci: nel riverbero delle forme, nella nebbia avvolgente che preclude allo spazio di determinarsi in facili proporzioni. Il calcolo in loro si apre in un universo illimitato, le cose si sfaldano come elementi immateriali o equorei. Le immagini acquistano il sigillo dell’impalpabile, dell’imponderabile e ogni gesto, nella loro opera, diviene rifiuto di qualsiasi legge precostituita. Ma se la pittura può essere soltanto uno specchio parziale della realtà, poiché è limitata nei propri mezzi semantici e coloristici, dandoci della bellezza dell’universo “soltanto un’interpretazione piuttosto libera e frammentaria”, soltanto la musica, Debussy pensava, ha “il privilegio di captare tutta la poesia della notte e del giorno, della terra e del cielo; di ricostruirne l’atmosfera e di ritmarne l’immensa palpitazione”. Quei segni naturalistici, anche se tanto liberi, non rimandavano sempre a qualcosa di concreto e di definito? Quelle chiazze di colore, quei grumi di vento, quelle gocce d’infinito, non evocavano ogni volta qualcosa di già visto? Così il suo spazio musicale diveniva un mondo incantato, un luogo inedito che sovrastava le forme; un mondo più elevato, che tuttavia sapeva cogliere dall’universo pittorico e naturalistico, infiniti suggerimenti. In questo modo l’arte si evolveva, e attraversando le pianure figurative, dirigeva il proprio sguardo verso gli orizzonti dell’indeterminato.
Nascevano nuovi autori. Quando Gauguin dipingeva, non pensava a ciò che poteva rappresentare, ma a quello che poteva evocare. Pensava con stupore alla parte musicale che era destinato a prendere il colore nella pittura moderna. Quel colore “che è vibrazione come la musica, ed è capace di raggiungere ciò che c’è di più generale, di più vago nella natura: la sua forza interiore”. L’essenziale di un’opera d’arte – Gauguin pensava – rimaneva sempre in uno spazio nascosto, in un altrove, dove l’importanza di quello che non è espresso bilancia il fascino della composizione. Anche Whistler credeva che se la natura contiene in sé tutti i colori e le forme, sarebbe stato limitativo dipingere solo quei colori e quelle forme, mentre la vera armonia nasceva da accostamenti preziosi, riferimenti indiretti e ambigui. Intitolando i suoi quadri con nomi musicali: “sinfonie”, “notturni”, alludeva continuamente ad un mondo ulteriore. L’arte figurativa, abbandonando lentamente il porto della rappresentazione, si avventurava sempre più nel mare dell’astratto e dell’informale.
Se l’Impressionismo aveva cantato le bellezze della natura, le forme del paesaggio, i timbri dell’acqua e dell’aria, i pittori simbolisti (Moreau, Redon, Bresdin, Puvis de Chavannes), vollero spingersi oltre, tessendo “un contrappunto visionario, onirico, fantastico”, con le ombre abbandonate della natura. “Se l’Impressionismo aveva mutato il valore delle forme, della visione”, essi vollero mutare “i valori dei contenuti, della visione stessa”, e nella loro concezione l’arte non manifesta, non rappresenta, “ma rivela per segni una realtà che è al di là o al di qua della coscienza”. Gli oggetti, le cose, si trasformano in gesti di una realtà inconscia: in immagini, in rivelazioni, in simboli: i simboli “di un’esistenza trascendentale e profonda, la cui infinità sfugge all’apprensione dei sensi e alla riflessione dell’intelletto.”
Come diceva Corot, Redon amava “mettere sempre accanto ad una certezza un’incertezza”; amava confondere i riferimenti del finito, la sintesi del fatto con l’indistinto, lo sfumato, il mistero. Per quanto bella, la realtà non bastava più. La sua volontà, il telescopio del desiderio, andava oltre, penetrando in quelle regioni sconosciute delle cose, microscopiche o macroscopiche, che fondano l’universo. Si scopriva l’infinitamente piccolo o l’infinitamente grande, e le sue figure si sfaldavano in un pullulare impercettibile, la materia si trasformava in un brulichio appena animato, il profumo degli elementi si dilatava in una pioggia di timbri. L’invisibile prendeva forma. Il biologico diventava psicologico, l’organico astratto, la materia si squarciava in luce, come quei suoi vasi di fiori, coloratissimi, sontuosi, abbaglianti, che “deflagrano, punteggiano la tela di tante minute esplosioni, si caricano di allusioni cosmiche fino a trasformarsi in costellazioni, in nebulose spaziali”. Delineandosi come oggetto misterioso, come simbolo, la natura divenne il luogo ambiguo tra la realtà e il fantastico, il visibile e l’invisibile; e la foglia o il fiore, con il loro disegno arabescato, divennero l’anello mancante di quella catena impossibile. Parlando del suo primo figlio, morto appena nato, Redon scrisse: “Mi sembra che alla mia morte, quando andrò a dormire come lui nello stesso ignoto, delle onde invisibili si avvicineranno per confondersi, provenienti da lui, provenienti da me”. Le onde appena percepibili di quel mare spirituale.
Come Redon, così Debussy ricercava, con l’evocazione naturalistica, quello strumento che faceva vibrare le armonie segrete dello spirito, immergendo le sensazioni nella comunione del Tutto. E il loro occhio, come il pallone bizzarro di Poe, si dirigeva nelle regioni ignote dell’infinito, dove il minimo si unisce al massimo, dove la materia trapassa nello spirito, dove questo è quello.
la musica di New York
Ci sono città storiche, città culto, città mitiche. Molte risiedono nei luoghi rarefatti del tempo; alcune sopravvivono in fastose ed eleganti rovine; altre ci sommergono con la loro dirompente presenza. Fra queste, nel cuore della nostra civiltà, New York è la città delle città. Per la sua ingombrante fama si può nutrire sospetto, scetticismo, antipatia; per le sue immagini infinitamente moltiplicate nell’astrazione di migliaia di films, si può coltivare anche un’affettuosa simpatia – piacevoli, evanescenti ricordi di storie, personaggi, strade, luoghi. Ma, capitare nella sua concreta presenza, vivere nel suo interno, ha qualcosa di sorprendente. Un sogno può, un giorno, divenire realtà. Un ricordo lontano e sfumato può inaspettatamente farsi forma concreta. Molteplici immagini finte o improbabili possono improvvisamente imporsi come ineluttabile, viva presenza. Passeggiando a New York si ha la sensazione di camminare in un luogo astratto, vagamente familiare, già vissuto; uno spazio che, in qualche modo, ci apparteneva; ma, proprio nell’istante in cui le nostre scarpe percorrono quei marciapiedi, esattamente in quell’attimo in cui i nostri sguardi incontrano quelle famosissime torri di acciaio e vetro, diventa insieme presente e lontanissimo, ineluttabile e remoto. New York è una città astratta, una città mentale. Tutto è calcolo, tutto è geometria: le ampie strade che la percorrono e la dividono con rigorose linee verticali e orizzontali; i grattacieli altissimi o i semplici palazzi che ritmano la sua misura come solenni note di una solenne sinfonia; un fiume ininterrotto di eleganti automobili e di festosi taxi gialli, come un liquido drago mansueto e benevolo; un immenso parco centrale: presenza vegetale, fantasiosa, organica, anch’essa inquadrata in uno spazio rigorosamente razionale. Ma, nonostante questi ritmi saldamente geometrici, oltre questa dimensione spiccatamente logica, Manhattan possiede un ricco fascino: una allure, un colore, una magia indefinibile e musicale.
Tutto ciò che caratterizza la nostra civiltà, la nostra modernità, qui è emblematicamente rappresentato, documentato. Le più ampie strade del mondo, i più grandi negozi del mondo, le più confortevoli e luminose abitazioni della terra, dove i ricchi e i super ricchi di ogni nazione hanno almeno uno spazio di rappresentanza. Ma New York non è soltanto fasto, consumismo, folla, sontuoso benessere. Famosi musei raccolgono, al suo interno, una sorprendente varietà di opere d’arte. Dagli antichi egizi all’arte concettuale, dagli assiro-babilonesi al post moderno, come un immenso specchio questa metropoli riflette i colori, le forme, il gusto delle variegate espressioni del mondo. Anche questo fa parte della sua grande vocazione ordinatrice: tutto può avere un senso, un suo giusto ritmo; tutto deve essere documentato e apprezzato e amato. New York è il mondo; il mondo è New York: nel bene che appare e nel male che si nasconde. Città fastosamente cosmopolita, essa contiene tutte le razze. Una sorprendente macedonia di volti. Un brulichio fittamente cromatico. È stupore vedere in questo spazio relativamente limitato la concentrazione etnica della nostra terra. È bello vedere coppie miste, neri con bianchi: europei con asiatici, nordici e mediterranei, africani e scandinavi congiungersi in questo luogo come in un nuovo, illimitato grembo. Uno spazio geometrico, razionale, sa contenere in sé tutti i colori, tutti i contrasti, tutte le voci del globo.
Circondata da grandi specchi d’acqua, Manhattan ha una forma famosissima e inconfondibile: è un’isola, un luogo delimitato, uno spazio a sé, autoreferenziale, una scacchiera di luce che comunica con l’esterno attraverso alcuni esili ponti; è un contenitore di luminosi parallelepipedi; è una moltiplicazione frenetica di specchi e di uomini; è un rettangolo infinitamente moltiplicato dal microcosmo al macrocosmo: dalla finestra alla strada, dalla piazza all’automobile, dalla parete di vetro allo skyline; è un’inedita astronave i cui elegantissimi grattacieli appaiono come misteriosi meccanismi; è un diamante levigatissimo di grigi e avorio, seta e oro. Manhattan è un giocattolo: originale, fantasioso, improbabile; un immenso gioco dove ciascuno di noi può proiettarsi con gioia o con odio, con desiderio, indifferenza, antipatia, passione. L’entusiasmo, l’euforia che ci pervade vivendo in questa metropoli, è molto simile alla gioia che coglie il bambino al contatto di un nuovo, ricchissimo giocattolo. Attraverso questo festoso meccanismo di forme e di luci tutto può succedere, tutto può realizzarsi. E la realtà non è solo il concreto. Passeggiando di sera a Time Square, si è sopraffatti dal vigore dei colori, dalla forza delle immagini, dai riverberi degli schermi – alti, efflorescenti, enormi – che producono una meta-realtà: la realtà del desiderio, del movimento, di ciò che può accadere, che lì, in forma virtuale, è possibile e semplicemente accade. Come un immenso giocattolo, New York ha questa felice facoltà di assecondare il desiderio, più desideri: di catturarli, accarezzarli, lusingarli, moltiplicarli, in un sogno insieme reale e fantastico, concreto e virtuale. Ma qualsiasi desiderio realizzato è un attimo, un istante, che subito si esaurisce ritrovando presto il suo slancio vitale. New York sembra non avere storia; tutto è presente, tutto è immediato. Non c’è tempo per una certa riflessione; certe case possono essere vecchie, ma il peso, la stanca vernice della malinconia non appartiene a questa astratta isola saldamente arroccata sopra la solida montagna del presente. Da Manhattan ci si può sporgere, contemplando il fragoroso baratro del passato o il rarefatto richiamo del futuro; ma tra queste metalliche sfingi a forma di levigate torri, tutto avviene qui ed ora.
La moltiplicazione delle immagini; il furore delle avventure; la costruzione delle storie. Un simbolo di questa meta-realtà sono sicuramente gli splendidi negozi, i bellissimi musei, e, non ultimo, il Metropolitan Opera: l’operificio internazionale in cui vengono prodotte un numero impressionante di opere. Come New York, anche il melodramma è un luogo virtuale: un gioco, una finzione, una maschera, un simbolo, un dramma. È un rettangolo delimitato dove può avvenire qualsiasi cosa: dove s’incontrano le persone più disparate, i personaggi più interessanti, le presenze più false e sublimi. E poi, naturalmente, c’è il suono, il grande paesaggio della musica: ora celeste ora terrestre, ora leggero ora pesante, ora frivolo ora drammatico; il ricco arabesco di forme impossibili che riveste con la sua invisibile struttura il ritmo delle danze, i gesti delle braccia, il significato delle parole, la forza delle storie, il fasto delle scene. Anche l’elegante geometria del Lincoln Center – un bianco rettangolo rilucente tra acque e cristalli – produce nel proprio seno il turbine del mondo: lo moltiplica, lo esalta, lo rappresenta nella sua intima essenza di specchio e di maschera, di verità e finzione.
Si può uscire da una delle molte, piacevolissime serate del Metropolitan Opera, ritrovandosi a passeggiare nel cuore di Manhattan: i grattacieli esaltano la loro imponenza, lo sfavillio delle luce è ancora più festoso, la tenue cenere della notte sembra esaltare il fuoco di quei misteriosi cubi che si dissolvono nell’aria. L’armonia pitagorica sembra governare ogni cosa: c’è respiro, serenità, eleganza, un murmure infinito di verticalità e grazia. Anche il caos delle strade sembra il più indicato basso continuo su cui s’innalzano queste colonne di cristallo. Allora New York diventa l’immagine di un grande organo celeste: la città più potente e materialista del mondo si è trasformata in un suono vertiginoso, in cui quelle torri imponenti e leggere sono le vibranti canne di uno strumento sconosciuto e magico. Ancora una volta tutto è moltiplicato: il suono è estatico silenzio, il peso diviene slancio e luce, la materia si è trasformata nel vortice di un vento inesplicabile e amico. Gli specchi dei grattacieli, con alcune loro punte coronate di nuvole, riflettono i lontani bagliori del cielo e delle stelle.